La carestia a San Donato nell'anno bisestile 1764
- 24 giu 2017
- Tempo di lettura: 14 min
Aggiornamento: 11 apr 2021
di Rosanna Tempesta
«Nell'anno 1763 fecesi un sterilissima ricolta, poiché fu tale la siccità dell'estate, che a riserba di pochissimo grano, secina ed orzo, e rarissime olive, niente affatto si raccolse di miglio, di legumi, di ghianda, e di altri frutti arborei; se non che fu raccolto alcun poco di grand'india, dove però potè adacquarsi, con acqua de' fiumi perenni: e d'uva pur tanto poco, che se ne pagò il mosto 25 carlini la salma, e il vino si vendette a cinque ducati.
Per la totale mancanza delle ghiande, vi fu la scarsezza de' salati, talché ebbero a pagarsi sino a dieci e dodici carlini la decina. Non si trovava un ovo, perché le galline per mancanza del miglio, e del pane, quasi tutte furono mangiate. Da pertutto era cresciuto il numero delle anime, ed in questa terra di Sandonato, nostra Patria se ne numeravano 2700 ed al pari era cresciuta ne' popoli la povertà, onde maggiore era il bisogno dell'abbondanza, quando maggiore sopravvenne la scarsezza del vitto.

(Foto di Nino Cardarelli)
Sebbene i terreni da molti anni addietro a' poco a' poco indeboliti dalla frequenza del seminare, si erano ridotti a rendere tanto poco frutto, che i migliori non arrivavano a rendere più del cinque a tomolo, tuttavia per l'abbondanza delle misture, raccolte ne' due anni antecedenti, in questo anno 1763 si ritrovava appresso de' negozianti non poca quantità di grano vecchio. Ciò non ostante perché attesa la detta mala ricolta, tutti, che potevano, e specialmente i fornari della comunità correvano a folla a comperare grano dove si udiva trovarsi: andava questo da giorno in giorno sempre" più crescendo di prezzo, e diminuendosi nella quantità in tutti i luoghi: onde si prevedevano cattive conseguenze sopratutto scarseggiava la capitale del regno. Chepperò la Regenza (Trovandosi il Re Ferdinando IV della casa Borbona in età pupillare) nel mese di settembre spedì ordine generale che ogni uno sotto rigorose pene dovesse far rivelo della quantità del grano, grand'india ed orzo che teneva, ed era asceso il prezzo del grano sino a 22 carlini il tomolo; quando alli 3 di novembre del medesimo anno 1763 fu spedito altro real editto generale, ordinante sotto rigorosissime pene di non potersi contrattare la vendita del grano, grand'india ed orzo oltre della voce stabilita ne' luoghi da cui prendevano norma l'altre populazioni delle rispettive Provincie: che non se ne negasse la vendita a chi volesse comprarne: e non s'impedisse il traffico. Quindi restò stabilito il prezzo del grano dove 15, dove 16 carlini il tomolo. In Alvito però, dal di cui mercato prendeva norma Sandonato, ed altre terre dello stato a' carlini 19 il tomolo.
Si trovava ancora presso de' cittadini di questa terra tanto grano vecchio vendibile, che sarebbe sopravanzato al mantenimento del pubblico forno della patria, a' qual effetto il popolo temendo la futura fame, adunato in pubblico parlamento, caricò a sindaci di farne la necessaria provvista a spese ed interesse del Comune. Altrettanto insinuavano i savi: e gli stessi possessori de' grani ne fecero l'offerta allo stabilito prezzo di 18 carlini il tomolo, ma i sindaci doppo averne comprato alcun poco insufficiente all'annona, ne lasciarono estrarre una gran parte. Così quando Iddio vuol castigare, leva il cervello.
Da tale fissazione de' prezzi nascevano diversi inconvenienti. I negozianti trovavano poco da comprare, e contrattando a prezzi fissi uguali o quasi uguali in ogni luoghi, non trovavano guadagno e perciò lasciarono affatto di trafficare. I fornari col panezzare a prezzi fissi nel suo luogo il grano comprato a prezzo fisso in altro luogo, oltre quello che perdevano di sottomano per aver la robba ci rimettevano la spesa del trasporto. Chepperò se ne fecero più ricorsi alla Reggenza la quale pensando dare a ciò rimedio, e tirare per via di traffico ai luoghi più bisognosi, e fra gli altri a Napoli che più di tutti penuriava; con altro editto spedito nel dì 11 di gennaro diede ogni licenza di potersi vendere e comprare ai mercati con libera contrattazione a quei prezzi che i venditori si facessero; ma vendendosi fuor di mercato si osservasse il prezzo stabilito come sopra col proibirsi a trafficanti di far magazzino: ma doversi trasportare le vettovaglie recto tramite ai mercati; e dove i fornari impotenti avessero bisogno di grano, sindaci provvederli a spese de medemi fornari: e nell'istesso tempo la medema Reggenza coll'illimitata potestà spedì a soccorrere per le Provincie il Regio Consigliere D. Gennaro Pallante sotto titolo di curare l'esecuzione del predetto editto e castigarne i trasgressori; ma infatti, per provvedere la Capitale di grano, siccome per pochi giorni fece seminando de terrori i Paesi; mentre piantava le forche dovunque andava affinché non segli occultassero i grani, che cercava, ma perché non ritrovò sufficienza di vettovaglia neppure nella Puglia fu il Consigliere richiamato in Napoli dalla Reggenza la quale sperimentando, che anche l'editto aveva partorito contrario effetto; mentre non servì che a fare più vivamente apprendere la strettezza della penuria universale, concepì pretenzioni di prezzi maggiori; conche porse occasione di chiudersi i granai, piuttosto che mandare a vendere ai mercati; non mancando scuse e pretesti, per non vendere in casa a' forestieri; talché si vedea sempre più abolito il desiderato traffico;
la Maestà sua con dispaccio de' cinque di febbraio rivocò ed annullò tutti gli editti ed ordini passati, perdonò qualunque contravvenzione commessa e lasciò i popoli nell'antica libertà di contrattare. Indi di giorno in giorno le vettovaglie andorono sempre più avanzandosi di prezzo. Si panezzava in questa nostra terra la pagnotta bianca di sei onze, e mezza, e la bruna di nove; ma consumatasi già quella scarsa provvista, che da' sindaci era stata fatta, nel dì 20 febbrajo salì il grano a trenta carlini il tomolo e calò la pagnotta bianca a quattronze. Quindi cominciò il popolo a tumultuare, schiamazzare, a minacciare saccheggio e morte contro de Governanti, che non aveano provisto per tempo a sufficienza, quando il grano valeva meno, siccome gli era stato insinuato, ed incaricato ed infatti più volte si avventorono ai sindaci nell'incontrarli per strada in atto di ucciderli onde gli convenne di fuggire e nascondersi. Due volte assalirono per saccheggiare la casa di uno di essi sindaci più facoltoso; ma' sebbene la prima volta furono rimandati appagati colle buone: la seconda volta la gente assalitrice ne' fu respinta a forza de' sassi, che si fecero grandinare dalle finestre. Due altre volte assalirono in casa un altro sindaco con animo d'ammazzarlo per essere stato il consigliere e principale cagione del mancamento, ma a fine buono, il quale perciò stimò liberarsi da quel pericolo, col rinunciar l'ufficio, siccome subito fece. Nel fine di febbrajo, per sedare il popolo, i sindaci, per concessione del vescovo, presero per carità da luoghi pii cento docati e di loro mano li distribuirono per limosina alle famiglie bisognose.
Secondo andavano le vettovaglie consumandosi, così andavano crescendo di prezzo. Nel principio di marzo ascese il prezzo del grano a quattro docati (quaranta carlini ndr) il tomolo onde si tralasciò di panezzare il pane bianco, ma solo pane bruno di quattr'onze l'uno di tutta farina sconcia, o concia a crivello, ed allo stesso prezzo di quattro docati il tomolo si pagavano le fave, e fagioli grandindìa il miglio si procurò per la sementa a più caro prezzo: l'orzo si pagava trenta carlini il tomolo ed i lupini comunemente a 25 carlini. Dalla stravaganza del prezzo è da immaginarsi la scarsezza delle robbe, la fame e la disperazione della povera gente. Nel dì 26 dello stesso mese di marzo, in occasione che il pane del forno si era consumato, e l'altro tardò alquanto a farsi, una gran truppa di popolo si portò con sacchi ad assalire il convento del Carmine, entrandovi per gli tetti al cortile, per torre dal granaro certo grano che si seppe, tenervi un forestiero affittuario di S. Croce, e perché i religiosi laici vollero opporsi, ne restò uno ferito da una stilettata pericolosa sulla spalla; sicché non valendo la resistenza, scassarono la porta del granaro e vi estrassero una porzione di grano, con portarselo in collo alle proprie case e a tal segno arrivò l'arroganza che uno degli assalitori se ne condusse a casa sua una soma carica sul mulo dello istesso convento e non è da tralasciare che i poveri di questo solevano ridursi in comitiva a picchiare alle case dei benestanti, da' quali essendo richiesti chi fossero, e che chiedessero, rispondevano essere la fame; chepperò conveniva rimandarli appagati per non irritarli alle violenze.
In più terre alla nostra convicine, ed in molte dello stato di Sora, per non esservi vettovaglie da macinare, s'erano chiusi i forni, e non si panezzava, se non quando gli riusciva, di estrarre segretamente, nottetempo qualche soma di grano o o d'orzo da' paesi confinanti, che non ancora l'aveano consumato. Imperocché in tutte le popolazioni che mantenevano aperto il forno, si mantenevano continuamente notte e giorno le guardie, perché non ne uscisse un acino di robba, o' vero una pagnotta e si ritoglieva e castigava chi si estraesse. Né si dava a passeggieri che una pagnotta; sebbene poco o niente si viaggiava, per non trovarsi da mangiare neppure nelle osterie, le quali per lo più si erano serrate. E simili miserie si trovavano ugualmente ne luoghi piccoli, come ne grandi. Nel fine di marzo in Roma si pagava la solita pagnotta due bajocchi l'una. Nella città di Napoli si stette tre giorni senza pane affatto. Onde il Papa Clemente XIII ne primi tre giorni di aprile fece di persona tre processioni di penitenza, per placare l'ira di Dio, e '1 simile fece il cardinale Arcivescovo di Napoli. E restarono esauditi co' grani capitati ad ambe le città alla volta del mare.
Accresceva fra noi l'afflizione il considerare che se non si seminava il grand'india, verrebbe a continuarsi la carestia anche l'anno seguente, e non se ne trovava la semente, che in Atina, per aver potuto adacquare, ne aveva ricolta qualche porzione. Chepperò se ne fece supplica da questa a quella università, la quale in grazia ne concesse cinquanta tomoli al prezzo di docati quattro al tomolo e di questo ne fu distribuito a' poveri cittadini una coppa a fuoco ma si errò nel consegnarla troppo per tempo, perché più d'uno, vinto dalla fame, invece di seminarla se la mangiò, lasciando in ozio le maesi, perciò fatte. A riserba della città d'Atina, che sul principio s'avea preparata una soprabbondante annona, e perciò non panezzò mai sopra trenta carlini il tomolo del grano; tutti gli altri paesi, ordinariamente dentro il mese di Aprile panizzavano a razione di sei docati il tomolo e stentavano a trovarlo. Il forno di questa nostra terra cominciò a panezzare a soli cinque docati non prima di Pasqua caduta alli 22 di Aprile in grazia di tali cittadini che gli somministravano. I sindaci che non vollero provvedere all'annona, quando il grano v'era in abbondanza a 18 carlini il tomolo, credendo che li cittadini ne tenessero in abbondanza, pigliorono un modo di farglielo dare a vii mercato. Colla spesa di 120 ducati procurarono una provisione Delegata al Rezzo Governadore di Sangiovannincarico a fare qui l'annona, quando il grano stava nel fine. Come infatti fattasi la cerca in casa di tutti i benestanti, con ispogliarli anche della sufficienza del vitto, non si potette adunare, che circa 70 tomoli di grano, e due o tre tomola di orzo; il quale grano, stabilitone il prezzo di trenta carlini il tomolo; a questa razione fu panezzato, e distribuito per mano di Denutati a' poveri cittadini.
Consumata fra pochi giorni la detta misera annona e non trovandosi dentro la terra, ne fuori chi somministrasse la vettovaglia, si cadde in tale calamità nel mese di maggio che alla povera gente conveniva cibarsi della crusca usata da Napoli dal grano corrotto che in quella città era capitato alla voltadel mare; la quale Crusca sí vendeva nei mercati dì Teano, Sessa, ed altri di quei luoghi a dieci carlini il tomolo, e poi rimacinata si vendeva in queste nostre parti sotto nome di tritello a lo carlini il tomolo, benché non ne uscisse pane di sostanza ne di consistenza; atteso per assioma: la brenta non fa pane. Insomma era tanto raro il grano che in più luoghi era pagato sette ducati il tomolo e talvolta anche dippiù. E da persone ritornate da' Puglia fu riferito che in Foggia il grano arrivò ad essere pagato sino a dieci ducati il tomolo. Circa il 13 del mese di giugno, cominciò a trafìccarsi l'orzo nuovo di fresco mietuto nelle parti di Capoa, ed ancor questo, benché quivi raccolto in abbondanza, al primo arrivo che fece in queste nostre parti non si pagò meno di trenta carlini il tomolo.
Dallo strano valore, e scarsezza de commestibili, può immaginarsi quale fosse il patire della povera gente. Parlando di questa nostra terra ella formava 400 fuochi, de quali appena 30 famiglie stavano provviste o' aveano potere di provvedersi; le restanti dovean digiunare per necessità. I cambieri non avean che mangiare, atteso quel poco grano che avean venduto appena bastò (a chi bastò) per seminare e vivere sino al tempo del seminamento. Gl'artisti non trovavano di lavorare, giacché ugnuno attendeva allo sparambio. I braccianti non trovavano da fatigare perché la spesa del vitto spaventava, anzi per la debolezza non potevano fatigare onde restò incolta gran parte del terreno. Di limosina se ne trovava poco perché quei, che la chiedevano, erano troppi e quasi tutti, la pagnotta consisteva in tre o quattro bocconi, e per saziare in un sol giorno la fame di tutta la famiglia; necessitavano più carlini; e per nutrirla sino alla nuova ricolta di solo pane, bisognavano molte decine di scuti e 'l danaro non v'era. Quei pochi stabili e mobili che i poveri possedeano erano stati già venduti per il vitto dei primi mesi della penuria. I furti, e furti furono da' pertutto innumerabili, ma perché condonabili per la necessità corrente, il Re infine mandò l'indulto a tutti i furti non eccedendo il valore di docati dieci. Cosicché non trovandosi altro modo da vivere, non si sentivache furti; e benché il Governatore su di ciò zelante, molti nemandasse frustando per la terra a suono di tamburo, e di continuo tenesse occupate le carceri, pur niente giovava; perchéappena usciti dalle carceri (donde doveano cavarsi perché nonvi morissero dentro) immediatamente ritornavano a rubare.
Ma neppure il rubare suffragava perché poco si trovava a rubare, ed ognuno vigilava con ogni cautela. Quindi è che i poveri cristiani costretti dalla fame mangiavano ciò che trovavano. Sul principio si nudrivano d'uve, e degli altri frutti chedi fuori si trovavano per la campagna. Passata la vendemmia, andavano cogliendo i squacquarelli, dico quei fichetti immaturi restati sugli alberi, i quali mangiavano cotti. Se trovavano per terra un acino solo di vettovaglia, lo raccoglievano e mangiavano. Indi cresciuto il bisogno, io più volte viddi le fecce del vino buttate sulla strada nella tramuta attorniate da più persone, che le mangiavano. Altri vedei raccogliere l'ossacrude buttate dal macello roderlo come cani. Più d'uno mangiò le carni degli asini morti buttati al vallone. Quei che teneano quantità di bestiami, anche d'altrui, pativano meno perché ne uccidevano e si cibavano delle loro carni, e le loro frutti, ne se ne dava il siero a' cani, perché si distribuiva a misura di cibo della famiglia. Ma questa sorta era di pochi. Un galant'uomo di Settefrati riferì che alla presenza sua una persona cavò dalla bocca di un cadavere, e mangiò il pane masticato, che il defondo avea trovato per limosina, e masticandolo era morto. II cibo ordinario e comune era di erbe silvestri di ognisorte che per la campagna poteano trovarsi. Ma coll'esperienza si provò che le sole erbe naturalmente non vagliono a sostanziare per molti giorni la vita umana, atteso che la povera gente così malnutrita, e per lo più senza condimento d'oglio e di sale, si vedea così maciata, indebolita, sfigurata e mal ridotta, che con difficoltà si riconoscevano le persone. I ragazzi comparivano così smunti e secchi che sembravano tanti etici. I giovani uomini, e donne si vedeano con tante rughe aggrinzati nella pelle del volto, che parevano tutti vecchi, anzi mummie. Si vedea un lutto commune: non si sentivano che lamentazioni, e faceva compassione vedere tanti poveri fanciulli e fanciulle distesi per le strade chiedere piangendo la limosina. Indi cominciavano a gonfiarsi nel volto, o nelle gambe, e questo era il preludio della morte; poi di là a poco rilasciati, morivano senza febre di mera debolezza e molti con iscioglimento di corpo. Cosicché rari erano i giorni in cui non si vedesse uno o più defondi e nelle terre convicine, dove specialmente stiede à lungo tempo serrato il forno, se ne sentivano morti sette ed otto il giorno, e si portavano a seppellire in chiesa senza suono di campane, e senza accompagnamento del parroco; il che in questa nostra terra non fu costumato che rare volte. In Alvito, ancorché mai non si chiudesse il forno, ne morirono 17 persone in un solo giorno.
La mortalità fu generale, ma dove più regnava la povertà, più fu numerosa; e dove mancava la comodità di comperare il pane fu eccessiva. In Settefrati e Gallinaro, dove rare volte s'apriva il forno, ne perivano in tanta copia, che ne restarono estinte molte intiere famiglie, e non vi restò gente bastevole a coltivare i territorii; i quali perciò rimasero, e per un pezzo rimarranno in gran parte inculti. La stragge maggiore, che l'inedia fece, accadde ne mesi di marzo, aprile maggio e Giugno, ne quali quattro mesi in questa terra di Sandonato morirono 143 persone, non compresi quei molti, che morirono fuor della patria, de quali fin'ora non si è ben appurato il numero. Tuttavia il numero dei nostri morti fu incomparabilmente minore di quegli degli altri paesi, per la ragione che in questa terra rare volte mancò il pane del forno, e n'era uscita quasi la metà del popolo a prò cacciarsi di fuori il vitto, molti colle loro fatighe in campagna di Roma, in Sonnino, in Puglia ed altrove. Altri limosinando nello stato papale, che meno penuriava ed altri finalmente a spesarsi ne due vasti serragli che il sommo Pontefice aveva formati in Roma, uno per gl'uomini e lo altro per le donne, ne quali accoglieva, ed a' sufficienza alimentava ogni sorta di poveri di qualunque paese; per il che fare, avea, come si disse, messa mano al tesoro di S. Pietro, conservato in Castel S. Angelo.
Tra cotanta stragge temendo La Reggenza, che dal fetore, che dalla moltitudine de cadaveri lungamente tramandava dalle chiese, dove erano sepolti, non si originasse un morbo contagioso, spedì ordine generale e premuroso, che da ciascuna comunità dovesse farsi scavare una profonda e larga sepoltura in campagna un miglio lontano dall'abitato, ed in quella farsi trasportare i morti, che accadessero, con sopraporre a' cadaveri la calce viva.
Dalla mità di giugno, cominciò da giorno in giorno a' calare il prezzo delle vittovaglie, perché continuò a venire l'orzo nuovo dalle parti di Capoa e cominciò a comparire ed offrirsi alla vendita la robba che si vedea avanzare all'annona fatta da alcune communità, ed alla provvista delle case facoltose. Ad ogni modo, perché a poveri non era restato alcun modo di comprarne, si diedero a nutrirsi delle spighe d'orzo, e del grano primotico, ancorché tenero di latte, dovunque lo trovavano sino alla ricolta. A tali e tante miserie sopravvenne una ricolta mediocre di grano, abbondante d'orzo, più abbondante di miglio e grand'india, sebbene poco se n'era seminato ed abbondantissima di mosto; e la Reggenza per favorire la povertà, prevenne l'esigenza de' crediti, con ordinare, che delle vittovaglie date con polisa in credito in tempo, che correvano in tempo dei suddetti prezzi esorbitanti, il grano non si pagasse più di 24 carlini il tomolo, la secina non più di diciotto, il grand'india non più di sedici e l'orzo non più di dodici.
Ma non per questo lo sdegno di Dio si vidde placato. La buona raccolta venne immediatamente seguita da un pessimo morbo epidemico, che si sparse generalmente da' per tutto, con tale malignità, che quei che attaccava, li privava affatto di forze, e de' sensi; e quei che non uccideva, li riduceva almeno all'articolo di morte, e dove il morbo entrava in una casa, pochi, o nessuno de domestici lasciava esenti dal suo veleno, e poi lasciava una lunghissima convalescenza, senza vigore aliuno, ne faceva eccezione di persone, perché equalmente infestava quei che non avevano patito la fame, come quei che l'aveano patita. E fra gli altri a noi tolse di vita il parroco fu D. Nicola Abbate Salvucci. Questa gran malattia in ogni paese fece molta stragge; ma più che ogni altra popolazione flagellò quella della città di Napoli, dove dentro li mesi di luglio e di Agosto, ne morirono tante migliaia di persone, che si stimerebbe un'iperbole a ridirsi. Non più si vedeva nelle strade la frequenza della gente, ma un continuo traffico di carri carichi di cadaveri, che si trasportavano a seppellire lungi dall'abitato, onde dubitandosi che non fusse una peste ognuno che potè, se ne fuggì dalla città la quale perciò per allora restò quasi spopolata. In detta città di Napoli, secondo le relazioni venute, si numerarono morti, si dell'inedie, come della epidemia cento ottanta mila persone, e de Paglietti tremila in circa. Pensarono i Napolitani che tanta ruina era loro venuta dall'aver mangiato il pane del grano guasto, venuto per mare, e perciò lo fecero tutto buttare a mare. Ma non si apposero, perché le altre popolazioni che avevano mangiato simil pane fetente del grano navigato, non incontrarono simil disgrazia. L'uno e l'altro castigo venne da Dio, che umiliat et sublevat: e così volle la capitale a terrore di tutt'il Regno» (2).
Tratto da: Memorie dell'abate Carlo Coletta.
E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DELL'ARTICOLO
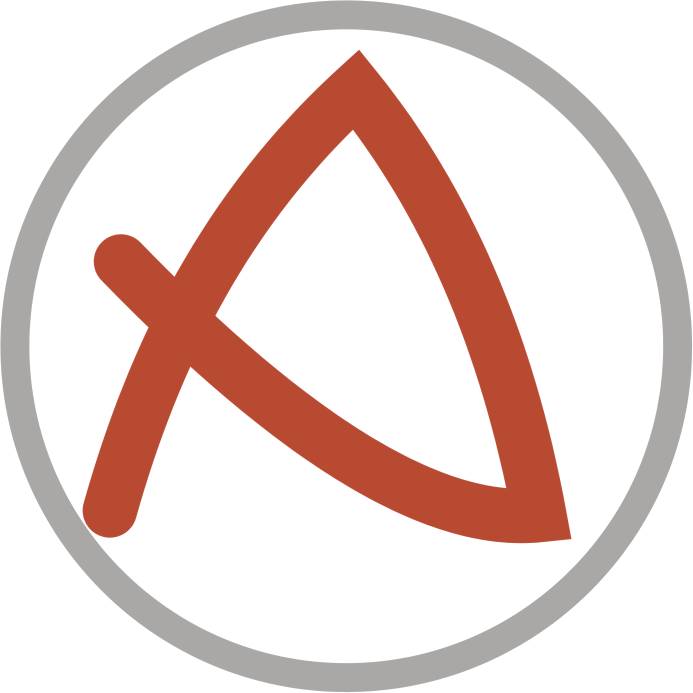








































Commenti