L'Apokolokyntosis di Seneca: una satira menippea raccontata dalla Val di Comino
- ferdinandomarfella
- 17 mar 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 31 lug 2025
[di FERDINANDO MARFELLA] - L'Apokolokyntosis (dal greco "ἀπολογία" [apología] e "κόνυξ" [kónyx] che significa "trasformazione in zucca", o "apoteosi") è una breve satira menippea scritta da Seneca. È una parodia dell'“apoteosi” (cioè, del processo con cui una persona viene elevata al rango di divinità) di Claudio, l’imperatore romano che morì nel 54 d.C. e fu poi divinizzato. L’opera si distingue per il suo tono satirico e per la critica pungente nei confronti della politica romana e della divinizzazione degli imperatori, che Seneca vedeva come un atto vuoto e ridicolo.
Ne parliamo in quanto si tratta della prima opera come scenografo titolare di Giuliano Tullio, scenografo Rai nativo di San Donato Val di Comino.

L'Apokolokyntosis di Seneca è un'opera che fa parte del genere letterario della satira menippea, che prende il nome dal filosofo greco Menippo di Gadara. Questo tipo di satira si caratterizza per l'uso di un tono burlesco e l'intreccio di riflessioni filosofiche e critiche sociali, ma con un linguaggio vivace, ironico e a volte grottesco.
Sebbene l'opera non sia giunta fino a noi in forma completa, essa è considerata uno degli esempi più importanti di questo genere. Seneca utilizza il testo per fare una critica radicale alla società romana, alle sue ingiustizie, e soprattutto ai difetti morali e intellettuali dei suoi contemporanei. La satira, pur trattando temi filosofici, non è priva di un forte componente critica nei confronti della vanità umana, delle false credenze e delle disuguaglianze sociali.
Seneca, filosofo stoico, riflette sul contrasto tra la vita "vera" secondo la filosofia stoica e le convenzioni sociali e culturali dell'epoca. Sebbene il suo stile non sia completamente rivoluzionario (in quanto la satira menippea era già stata sviluppata da autori precedenti), la sua combinazione di umorismo e filosofia si distingue per l'approfondimento psicologico e il suo taglio moralistico.
Le sue idee e il suo stile hanno influenzato non solo la letteratura latina, ma anche la tradizione della satira nei secoli successivi, da autori come Giovenale a scrittori moderni.
Contenuto e Tono
L'Apokolokyntosis è una satira che gioca sul concetto di "divinizzazione" degli imperatori romani. In questo caso, Seneca immagina l’imperatore Claudio che, dopo la sua morte, si presenta davanti agli dèi nell'oltretomba, ma anziché essere accolto con onore, viene deriso e scacciato in modo comico. La satira si concentra sul fatto che la divinizzazione di Claudio non ha alcun fondamento divino o morale, ma è un atto puramente politico e ridicolo.
In modo parodistico, Seneca ridicolizza le cerimonie religiose e le pretese di divinità degli imperatori, suggerendo che in realtà Claudio fosse più simile a una figura grottesca che merita solo una risata, piuttosto che un posto tra gli dèi. La satira in questo caso si rivolge a un potente della Roma imperiale, smascherando l’assurdità della sua "apoteosi".
Stile
L’opera è scritta in uno stile brillante, caratterizzato da un umorismo tagliente e da un'ironia mordace. Seneca mescola elementi della filosofia stoica con un tipo di satira sociale che critica le istituzioni e le convenzioni politiche dell’epoca. Il linguaggio è spesso sarcastico e carico di allusioni al potere e alla corruzione.
L'Apokolokyntosis non è solo un attacco personale a Claudio, ma una riflessione sul potere, sull'onore e sulla natura dell'apoteosi stessa, tematiche che Seneca esplorerà anche in altre sue opere. In questo caso, Seneca usa la forma satirica per scardinare la sacralizzazione del potere imperiale, riducendola a una burla.
Perché è importante
L'Apokolokyntosis è uno degli esempi più famosi di satira politica di Seneca e dimostra la sua abilità nell'usare la forma satirica per esprimere il suo disprezzo per i vizi della classe dirigente romana. L'opera ha anche una grande importanza storica, poiché offre uno spunto di riflessione sul fenomeno della divinizzazione degli imperatori, un'usanza che sarebbe continuata nei secoli successivi.
La testimonianza di Giuliano Tullio, scenografo RAI senior
GIORNALISTA RAI ARMONIA: Incontriamo lo scenografo Giuliano Tullio, progettista di grande spessore culturale e umano. Titolare dal 1969 presso la sede Rai di Napoli, lavora per romanzi sceneggiati, prosa, opera, varietà e trasmissioni per ragazzi, collaborando con autori e registi di chiara fama. Oggi è tornato a vivere nella sua terra d’origine, San Donato Val di Comino, posta nel Parco Nazionale d’Abruzzo, in un punto di crocevia con il Lazio, territorio ricco di montagne e valli la cui bellezza lo ha più volte ispirato nell’ideazione scenica, come lui stesso ci racconterà. La sua formazione artistica, in realtà, avviene a Roma, dove frequenta il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti di via Ripetta. Nel 1960, mentre frequenta il quarto anno, un funzionario Rai, Ezio Polloni, si reca all’Accademia con l’allora responsabile della scenografia, Sig. Rinaldi, per selezionare gli alunni di maggior talento da avviare alla Rai: così Giuliano, segnalato dal suo professore di scenografia Peppino Piccolo, già dal 1961 comincia a collaborare con la Rai di Roma, ancora prima di diplomarsi. Nei primi anni collabora con contratti a tempo determinato ed artistici, per essere assunto stabilmente nel 1969 dopo aver vinto un concorso per scenografo di primo livello, bandito dal Centro di produzione di Napoli. Nella sede Rai di Napoli, in realtà, ha già lavorato firmando in particolare nel 1963 la sua prima scenografia da progettista effettivo.
GIULIANO TULLIO: Ero nella sede di via Teulada ed il prof. Polloni mi chiese se fossi disponibile ad affrontare da titolare la trasposizione televisiva dell’Apokolokyntosis (Ἀποκολοκύντωσις in greco), opera satirica di Seneca, nella versione messa in scena al Teatro di Ostia Antica dalla Compagnia Italiana del Teatro, diretta da Giuseppe De Martino. Naturalmente accettai con entusiasmo ma, essendo alle mie esperienze, mi scontrai con la difficoltà di adattare al piccolo studio 1 del centro di Napoli, un allestimento pensato per lo spazio del teatro romano, naturalmente configurato con lo skené ed il golfo mistico, nel quale i coreuti sottolineavano le gesta abnormi di Claudio, la cui divinizzazione, quale imperatore romano, viene messa in parodia dall’opera come trasformazione in zucca o "zuccone". Mi ingegnai allora per realizzare un impianto multiplo ed ebbi un’intuizione che si rivelò vincente, ispirandomi alle strutture girevoli a tre facce del teatro greco: i periaktoi. La scelta di comporre la scena attraverso quinte carrellate e rotanti mi permise di far entrare ed uscire i vari ambienti dal piccolo studio di Napoli, sia durante le prove che nella presa diretta: la corte dei Cesari, l’Ade, l’Olimpo, il salone del triclinio e tanti altri.

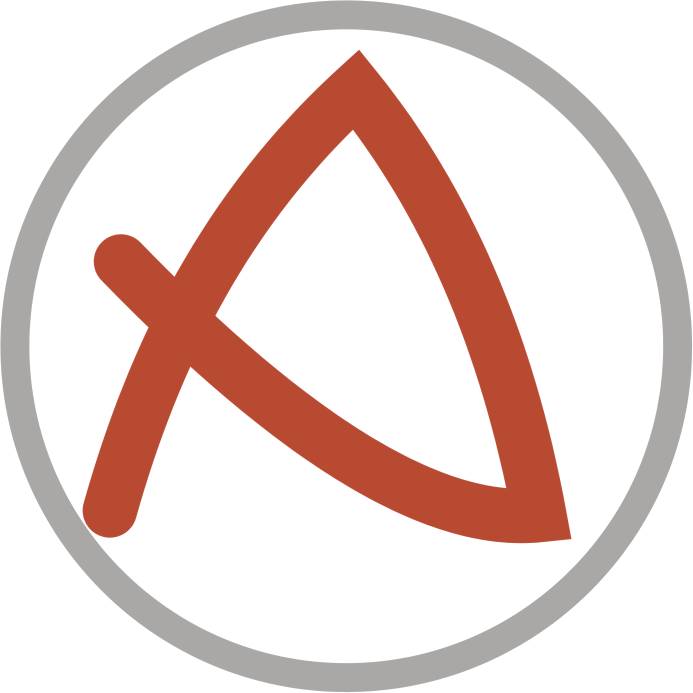









































Commenti