L’idraulica sanitaria nel suo sviluppo storico
- ferdinandomarfella
- 3 mar 2025
- Tempo di lettura: 5 min
Aggiornamento: 6 mar 2025
[di FERDINANDO MARFELLA] - Il 23 giugno 2018, la sede dell'Archeoclub d'Italia della Val di Comino organizzò ad Alvito un interessante convegno dedicato alla sanità locale nell'Ottocento, con relatori principali: il nostro presidente la professoressa Rosanna Tempesta, il dott. Giuseppe Monaco, allora socio. Personalmente, feci un breve intervento a margine con dei riferimenti all'evoluzione tecnologica in ambito civile-sanitario, inquadrandolo sia da un punto di vista storico che ingegneristico. Preparo spesso nei convegni in cui intervengo una piccola relazione, quando il tempo a disposizione si rivela essere più che sufficiente, basata su temi tecnico-ingegneristici.

Al tempo erano diffuse malattie epidemiche che falcidiavano le popolazioni che già vivevano in condizioni precarie di igiene e di alimentazione. L'ingegneria sanitaria cominciò a svilupparsi in Inghilterra e in Francia a fine Ottocento, giungendo nell'Italia post-unitaria tra 1880 e inizi Novecento.
Le acque potabili sono importantissime per la vita e il benessere di persone, animali e luoghi. Meno nobili ma non meno necessarie e importanti per la salute pubblica sono le acque nere, provenienti dagli scarichi. In seguito alle diverse pandemie di colera verificatesi in Europa durante l’Ottocento, fu avviato il risanamento pubblico che riguardò diverse città europee ed italiane. Durante la conferenza del 23 giugno 2018, ho utilizzato come fonte delle soluzioni sanitarie l’opera dell’ingegner Antonio Cantalupi “Della costruzione dei canali di fognatura” che riporta un interessante studio di fine Ottocento riguardante i sistemi fognari di Londra, Parigi, Berlino, Varsavia, Francoforte sul Meno, Bruxelles, Danzica, Milano, Napoli, Torino, Roma e Budapest.
Tale tematica coniuga da un lato il mondo delle acque, dall’altro gli aspetti sociali e sanitari della civiltà umana. Potrebbe sembrare questo un argomento di secondario rilievo rispetto ai grandi temi storici, ma quelle che potrebbero sembrare a qualcuno solo delle curiosità, sono in realtà soluzioni tecniche di avanguardia per i tempi, di sicuro e grande impatto sull’igiene delle città, trattandosi di opere civili grandiose ma nascoste ai più perché costruite sotto i piedi degli ignari cittadini.
Esempi di servizi igienici ben organizzate risalgono ad epoca romana. Esse furono costruite presso gli edifici termali: pensiamo a quelle ritrovate negli scavi dell’antica Aquinum, o quelle più famose ritrovate a Pompei che immancabilmente vediamo in tanti documentari, o ancora quelli rintracciabili ad Alba Fucens nella Marsica. Indubbiamente sono esistite anche nella antica Atina romana, soprattutto in concomitanza di edifici termali. Nel territorio della Val di Comino abbiamo a disposizione anche casi di latrine pensili in castelli medievali: possiamo fare riferimento in questo caso al castello di Vicalvi nel quale ancora oggi troviamo i resti di una latrina che scaricava lungo le mura del castello, giù in basso. Indubbiamente si trattava di luoghi spartani, per quanto ingegnosi per la concezione medievale, ma ancora non si poteva parlare di sala da bagno.

Una delle prime sale da bagno di cui si ha nota è quella voluta da Francesco I, Re di Francia, all’inizio del Cinquecento, per il castello di Fontainebleau nell’Ile de France. Molto più famose sono le sale da bagno a Versailles, realizzate durante il Seicento: gli ambienti sontuosi erano molto ampi, l’acqua corrente era solo fredda (ed era già tanto per l’epoca). L’acqua calda era trasportata con grossi mastelli e travasata da servi nelle vasche da bagno reali. Il riscaldamento degli ambienti avveniva tramite dei camini. Le sale da bagno erano difficili da riscaldare a causa degli alti soffitti, degli elevati volumi e degli spifferi d’aria gelida presenti ovunque.
All’epoca non esisteva la tazza del gabinetto. Si utilizzavano catini e orinali camuffati all’interno di panche o mobili richiudibili, spesso anche in fogge strane come grossi libri finti poggiati su capienti sgabelli. Nota è la diatriba anglo-francese sorta per stabilire la genitura della tazza da bagno. I francesi nel Settecento chiamarono la sala da bagno col termine “lieux à l’anglaise” quando ancora la tazza del gabinetto, ovvero il water closet, era ancora quasi sconosciuto agli stessi inglesi: persino nelle case dei nobili esso era un oggetto raro. Anche gli italiani si unirono all’uso dei francesi di indicare il gabinetto utilizzando termini quali “inglesina”, “mezza inglese” e “gabinetto all’inglese”.
Vennero introdotti i primi vasi capaci di convogliare le deiezioni tramite un collettore ma tutti i sistemi adottati avevano problemi seri: mancavano i sifoni per isolare i canali fognari dalle abitazioni che finivano per essere costantemente appestate da nauseabondi effluvi; spesso gli stessi collettori non erano capaci di convogliare verso i pozzi neri o i canali di scarico il materiale fecale poiché mancava una spinta tipica che li portasse via, come oggi avviene per l’effetto di depressione creato sotto al gabinetto dal sifone. Spetta proprio ai britannici il primo brevetto di un gabinetto capace di isolare con una valvola la tazza dai canali fognari trattenendo i cattivi odori dello scarico. Il brevetto fu di Alexander Cummings (1733-1814). Egli era un orologiaio scozzese ed inventore di vari strumenti e aveva il proprio negozio a Londra, in Bond Street. Inventò il water closet a valvola che permetteva di pulire automaticamente il vaso trattenendo i cattivi odori (brevetto del 1775): le toilette dei treni ad alta velocità o degli aerei ancora utilizzano un design di WC simile.

Joseph Bramah (1748-1814) era un ebanista inglese con spiccate doti di inventore. Considerato uno dei padri dell’ingegneria idraulica, inventò un modello di water closet a valvola che brevettò nel 1778, prodotto fino al 1890.
Nel solo primo anno di vendita vendette ben 6000 pezzi. Un esemplare d’epoca originale è ancora visionabile in un castello reale sull’isola di Wight, appartenuto alla regina Vittoria. Un altro esemplare di produzione inglese del 1839, in ottone, rame, ceramica, è esposto al Museo del Mare di Capoliveri, all’Isola d’Elba. Il water closet è completo del meccanismo per la pompa. La tazza esibisce un decoro “all’italiana” caratterizzato da scene marine e motivi fitomorfi nei colori del bianco, blu e azzurro. L’evanescenza del colore è dovuta alla lunga permanenza sul fondo del mare. Anch’esso è un oggetto molto raro e costituisce uno dei primi esempi di dotazioni sanitarie moderne su di un piroscafo per passeggeri. Si trovava all’interno di una toilette destinata agli ospiti di prima classe.
La svolta definitiva si ebbe grazie a Thomas Crapper nel 1886, con l’introduzione del sistema a sifone e l’utilizzo di una cassettina dell’acqua, tuttora in uso in tutte le nostre case di oggi. In tale modello l’acqua fa da barriera agli effluvi mefitici provenienti dalle fogne e contemporaneamente essa provvede alla pulizia della tazza tramite l’aspirazione che si crea per effetto sifone e ai moti vorticosi che provvedono a pulire le pareti dalle deiezioni.

References:
[1] - Antonio Cantalupi, Risanamento Delle Città: Della Costruzione dei Canali di Fognatura e dei Diversi Mezzi Impiegati per Tradurre all'Esterno le Acque Lorde e le Dejezioni; Studi e Proposte, Milano, Brigola, 1890.
[2] - Paolo Sorcinelli, Storia sociale dell’acqua, Odoya, 2016.
[3] - Lawrence Wright, La civiltà in bagno, Odoya, 2017.
[4] - Dal catalogo del Museo del Mare di Capoliveri (LI).
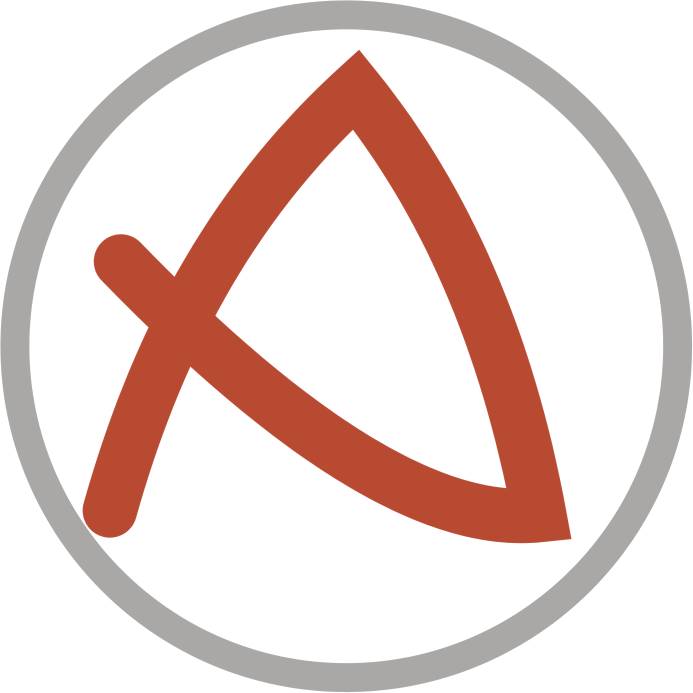









































Commenti