
Le gualchiere al tempo dei Gallio
- ferdinandomarfella
- 26 feb 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 27 feb 2025
[di FERDINANDO MARFELLA] - Le gualchiere per la lavorazione dei panni di lana sono menzionate nella Relazione familiare [1] redatta nel 1595 per il cardinale Tolomeo Gallio di Como. Questi opifici preindustriali sfruttavano l’energia idraulica per la follatura dei tessuti, un processo fondamentale per conferire compattezza e resistenza ai manufatti in lana. Tale processo permetteva di trasformare la lana grezza in un tessuto morbido, resistente e impermeabile. La loro origine risale all’epoca romana: Plinio il Vecchio, nel I secolo d.C., ne fa menzione nelle "Naturalis Historiae", sebbene le prime strutture pienamente sviluppate risalgano al Medioevo.
Durante l'Alto Medioevo, i Longobardi già utilizzavano rudimentali gualchiere, basate su mulini ad acqua adattati per la follatura. Tuttavia, la vera innovazione si ebbe tra il XII e il XIII secolo, quando in tutta Europa, e in particolare in Italia, si diffusero macchine più efficienti. L’adozione della ruota idraulica associata a un albero a camme permetteva di azionare i pesanti magli battenti, che colpivano i panni con ritmo regolare. Questo sistema migliorava notevolmente la qualità del tessuto, riducendo il lavoro manuale e rendendo il processo più uniforme.

Le gualchiere erano tipicamente collocate lungo corsi d’acqua, per sfruttare la forza motrice della corrente. L’edificio era suddiviso in due ambienti principali: uno dedicato alla ruota idraulica e agli ingranaggi di trasmissione, l’altro ospitava i macchinari per la follatura. Il cuore del processo era la "pila", una vasca dove i panni venivano immersi in acqua calda mescolata con sostanze detergenti come la terra da follone o l’urea, quest’ultima ricavata da urina fermentata. La terra da follone era una miscela di argille ad elevata plasticità, composta principalmente da minerali del gruppo delle smectiti. Questi silicati idrati di alluminio e magnesio possedevano proprietà altamente assorbenti e sgrassanti, rendendoli ideali per rimuovere impurità e migliorare la compattezza del tessuto. Nel Lazio, le migliori terre da follone provenivano dalla Tuscia, in particolare dalle zone di Civita Castellana e Nepi, feudi che, alla fine del Medioevo, furono assegnati da Papa Alessandro VI Borgia a sua figlia Lucrezia [2]. In Campania, invece, le aree di produzione più rinomate erano situate intorno a Capua e Aversa.
Il ciclo di follatura seguiva diverse fasi:
Immersione e preparazione: Il tessuto, già lavato e cardato, veniva posto nella pila con l’aggiunta dei detergenti naturali.
Battitura: I magli, mossi dalla ruota idraulica, colpivano ripetutamente il tessuto per diverse ore, infeltrendo le fibre e rendendo il materiale più compatto e resistente.
Risciacquo e asciugatura: Terminata la follatura, il tessuto veniva accuratamente risciacquato per eliminare i residui delle sostanze utilizzate e quindi appeso ad asciugare.
L’impatto delle gualchiere sull’industria tessile europea fu notevole: nonostante i costi elevati di costruzione e manutenzione, questi opifici permisero una produzione più efficiente e standardizzata, favorendo lo sviluppo del commercio dei panni di lana. In Italia, città come Firenze, Milano e Venezia divennero centri di eccellenza nella manifattura tessile proprio grazie all’adozione di queste tecnologie.
Nel Lazio, la presenza di gualchiere lungo il fiume Melfa già prima dell’arrivo dei Gallio alla fine del Cinquecento testimonia l’esistenza di una fiorente attività laniera nella regione. Così come erano diffuse lungo il Liri e tutti i suoi principali affluenti, in quanto erano vicine alle zone di pascolo dove veniva prodotta la materia prima. Purtroppo, le condizioni igieniche all’interno di questi stabilimenti lasciavano spesso a desiderare: la promiscuità tra operai e sostanze come l’urina (impiegata nella follatura) contribuiva a rendere l’ambiente malsano. Inoltre, il rumore assordante delle macine e dei magli, unito all’aria impregnata di vapori e odori acri, creava condizioni di lavoro estremamente difficili. Le condizioni dei lavoratori nelle nostre zone, a quei tempi, non erano certamente paragonabili a quelle di oggi.
Le gualchiere ebbero un ruolo centrale nella produzione della lana, che nel Medioevo e nel Rinascimento costituiva una delle principali attività economiche europee. Esse permisero di aumentare la produttività delle manifatture tessili, riducendo i tempi e i costi della follatura rispetto al metodo manuale. Le corporazioni di tessitori e mercanti della lana, soprattutto nelle città italiane e fiamminghe, fecero ampio uso delle gualchiere per migliorare la qualità e l’uniformità dei tessuti, rendendoli più competitivi sui mercati internazionali.
Con la crescita della domanda di tessuti pregiati, le gualchiere divennero parte integrante di un sistema produttivo più ampio, che includeva tintorie, filande e mercati specializzati. La loro diffusione contribuì alla nascita di vere e proprie economie urbane basate sulla produzione tessile, favorendo la creazione di reti commerciali che collegavano le principali città d’Europa. L’evoluzione delle tecnologie tessili nei secoli successivi avrebbe progressivamente migliorato l’efficienza della follatura, fino all’avvento delle macchine a vapore nell’era industriale. Tuttavia, la gualchiera idraulica rimase per secoli un elemento cardine della produzione tessile europea, contribuendo in modo significativo all’economia e all’organizzazione del lavoro nelle città manifatturiere.
A breve sarà disponibile il nuovo quaderno dell'Archeoclub Val di Comino dedicato al tema delle sue acque superficiali e sotterranee, dove saranno disponibili approfondimenti sul tema.
[1] - Il Ducato di Alvito nell’Età dei Gallio, Tomo II “Relazione familiare de lo Stato di Alvito fatta a l’Ill.mo sig.re Card.le di Como 1595”, Comitato per le attività culturali dell’Anno Gallio, Atina, MCMXCVII, p. 36.
[2] - Cfr. Lucrezia Borgia, imprenditrice nella Ferrara rinascimentale, in Donne di potere del Rinascimento, a cura di Letizia Arcangeli e Susanna Peyronel, Viella, 2016.
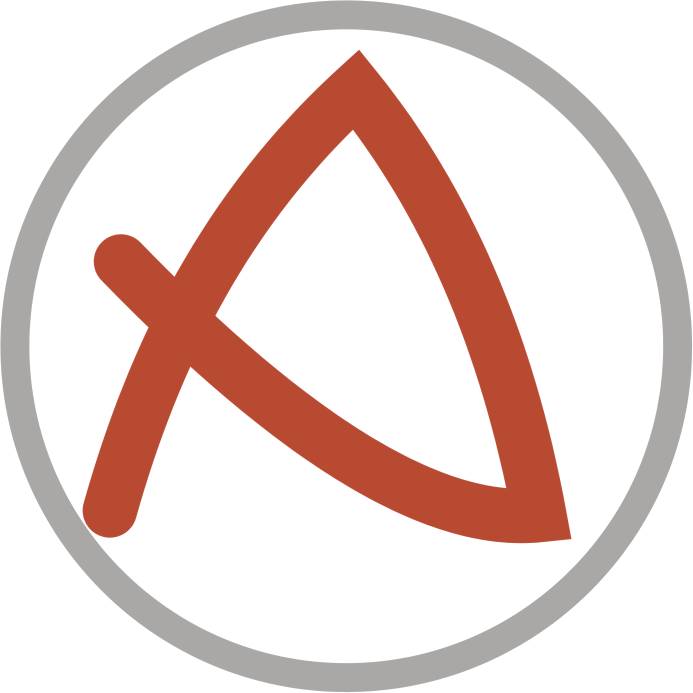









































Commenti